Credo profondamente nella serendipità, quella capacità unica che permette di cogliere connessioni impreviste tra idee e situazioni apparentemente distanti. Questa qualità è diventata un elemento cardine del mio lavoro, aiutandomi a interpretare la complessità della realtà alimentare e culturale che mi circonda. L’intervista con Antonio Pascale al festival ColtivaTo è stata proprio un’occasione di serendipità: una domanda inattesa sui miei progetti futuri mi ha spinta a riflettere profondamente sul mio percorso professionale e sulle scoperte maturate in oltre trent’anni di attività.
Dall’approccio descrittivo all’interrogazione critica
Guardando indietro, il mio lavoro non ha seguito un percorso lineare, ma si è sviluppato attraverso diverse fasi, ciascuna essenziale per approfondire il rapporto tra cibo, cultura e società. Ricordo con affetto i primi anni della mia carriera, caratterizzati da un approccio descrittivo focalizzato sugli aspetti identitari, materiali e simbolici del cibo. Tuttavia, sentivo che mancava ancora qualcosa: era necessario interrogare con maggiore profondità il “mistero del cibo”.
Le fondamenta bioculturali e antropologiche della mia formazione
La lettura del libro “A qualcuno piace piccante” di Gary Paul Nabhan ha rappresentato una svolta decisiva, introducendomi a una visione integrata delle scelte alimentari viste come adattamenti bioculturali concreti, risultanti dall’interazione tra ambiente, genetica e cultura. Altri lavori fondamentali nel mio percorso, da un punto di vista bioculturale, sono stati “Il seme di Pandora” di Spencer Wells e gli studi pionieristici di Luca Cavalli-Sforza, che hanno esplorato la storia genetica delle popolazioni umane, evidenziando come la diffusione delle pratiche agricole e alimentari abbia influenzato la nostra evoluzione e la struttura delle società moderne. Sul versante più strettamente antropologico-culturale, grande rilevanza hanno avuto gli studi di Vito Teti e Marvin Harris. Teti ha approfondito il rapporto tra cibo, memoria e identità culturale nelle comunità locali, rivelando come le pratiche alimentari siano al contempo segno di continuità e di adattamento ai mutamenti sociali e ambientali. Harris, con il suo approccio del materialismo culturale, ha analizzato il ruolo economico e sociale delle scelte alimentari, dimostrando come la cultura alimentare sia fortemente connessa alle risorse materiali e agli equilibri ecologici. Da queste letture ho abbracciato un’antropologia applicata, orientata alla soluzione concreta di problematiche reali come salute pubblica, sostenibilità e inclusione culturale. Da quel momento ho abbracciato un’antropologia applicata, orientata alla soluzione concreta di problematiche reali come salute pubblica, sostenibilità e inclusione culturale.
Il pane come simbolo culturale
Questo approccio applicato mi ha guidato nella realizzazione del libro “Storia e civiltà del pane“, nel quale ho cercato di mostrare come, nel tempo, si costruisce la complessità identitaria, simbolica ed economica di un alimento fondamentale per la cultura umana. Più che una semplice raccolta di dati, ho voluto esplorare le molteplici dinamiche che rendono il pane un elemento così significativo e trasversale nelle società.
Inclusività alimentare e turismo: nuovi orizzonti di ricerca
Negli ultimi anni la mia ricerca si è ulteriormente ampliata, affrontando temi come le dinamiche globali delle filiere alimentari, gli aspetti politici ed economici del consumo e la crescente necessità di inclusività culturale e religiosa in vari ambiti. In particolare, mi sono dedicata a esplorare le potenzialità del turismo enogastronomico inclusivo e dell’alimentazione inclusiva in ambito sanitario. Il turismo enogastronomico rappresenta un potente strumento per valorizzare le culture locali e promuovere lo sviluppo economico, ma per essere efficace deve rispondere alle esigenze alimentari e culturali di tutti i turisti, rispettando le loro specificità dietetiche e religiose senza tuttavia snaturare la cultura locale che li accoglie: la vera sfida consiste nel trovare un equilibrio tra accoglienza e la salvaguardia dei significati culturali locali, evitando semplificazioni e stereotipi. Allo stesso modo, nell’ambito sanitario, l’alimentazione gioca un ruolo cruciale non solo nel supporto nutrizionale ma anche nel rispetto delle diverse tradizioni e credenze religiose dei pazienti. Sono convinta che un approccio multidisciplinare e innovativo in questi settori permette di valorizzare la diversità culturale e migliorare significativamente la qualità della vita delle persone e delle comunità coinvolte.
Progetti futuri (anche per i giovani antropologi)
Nel 2026, infine, è prevista l’uscita di un nuovo libro dedicato all’antropologia della pasta, che offrirà una prospettiva innovativa e multidisciplinare sull’importanza storica, culturale e sociale di questo alimento. Più volte, nel corso della mia carriera, studenti e giovani antropologi mi hanno chiesto come intraprendere questa professione e diventare antropologi dell’alimentazione. Credo che la risposta risieda proprio nella capacità di mantenere aperta la mente alle molteplici connessioni tra cultura, ambiente e società, affrontando concretamente problemi reali e costruendo un sapere pratico che possa realmente influenzare il presente e il futuro.
Mi auguro che il racconto del mio percorso possa essere di ispirazione e incoraggiamento per chi si avvicina a questa disciplina, mostrando loro come sia possibile coniugare ricerca, passione e impegno sociale nella complessa realtà alimentare contemporanea, e come la serendipità, spesso, possa rappresentare la chiave per scoprire nuove connessioni e aprire porte inattese nel proprio cammino professionale e personale
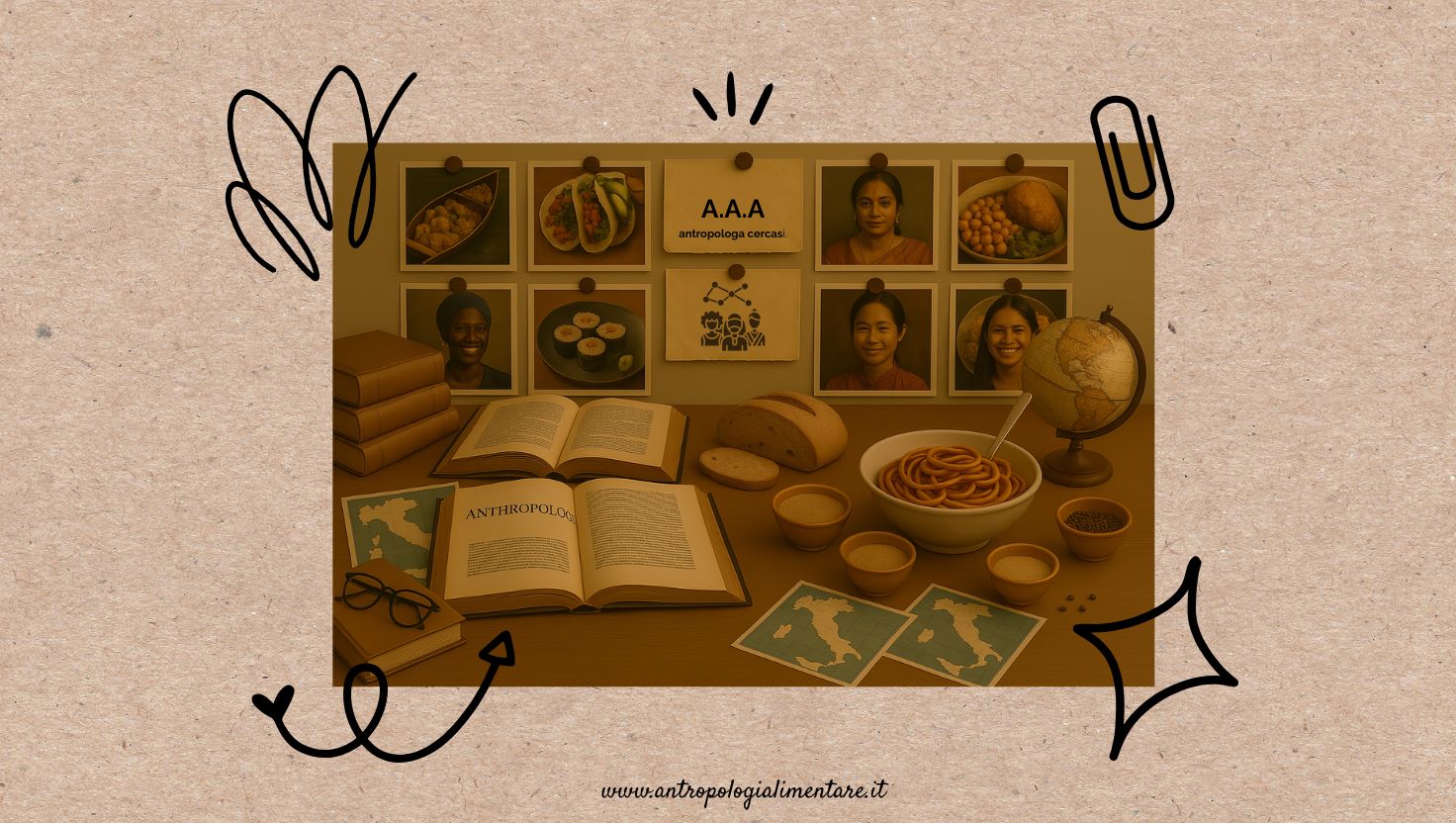
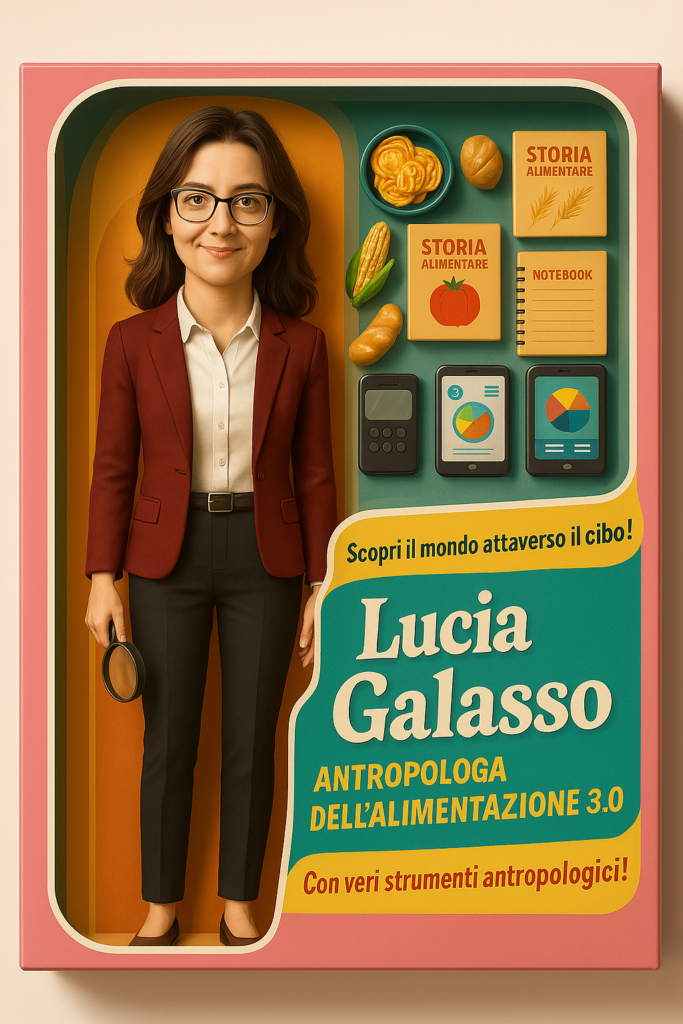

No Replies to "La mia antropologia dell’alimentazione? Una riflessione tra serendipità, ricerca e nuove sfide"